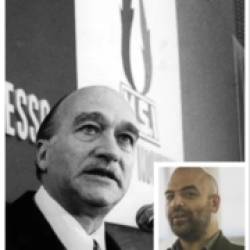”La storica richiesta delle famiglie degli infoibati e delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati per revocare l’onorificenza conferita al dittatore jugoslavo Josip Broz Tito, ha finalmente trovato esito positivo attraverso l’approvazione di un ordine del giorno a mia prima firma, che impegna il governo ad attivare la procedura di revoca del cavalierato di gran croce, decorato di gran cordone, da parte del Presidente della Repubblica”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Roberto Menia, primo firmatario dell’odg approvato in Commissione Cultura del Senato in sede redigente del ddl in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell’esodo giuliano dalmata nelle giovani generazioni.
__________________________________________
AS 317- 533 -548
ORDINE DEL GIORNO
Il Senato della Repubblica,
nell’approvare nuove norme di modifica alla legge 30 marzo 2004 n. 92 con le quali si prevede la realizzazione di iniziative tese a diffondere la conoscenza della tragedia delle foibe;
ricordato che
con la citata legge «La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale “Giorno del ricordo” al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale”
a prescindere dalle non sempre convergenti ricostruzioni storiche – ed in presenza di marginali tesi negazionistiche o riduzionistiche – è ormai riconosciuto lo sterminio di diverse migliaia di italiani, infoibati, deportati, massacrati nelle forme più atroci dai partigiani di Tito, in gran parte a guerra finita;
il capitolo delle foibe e del terrore titino fu prodromo dell’esodo di 350.000 italiani dall’Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, determinando la lacerazione di un tessuto storico da cui scomparve quasi del tutto la presenza italiana e si cambiarono i connotati di terre intrise da secoli di storia, lingua, cultura italica;
giova in proposito ricordare che il recente censimento in Croazia ha certificato la presenza di soli 13.000 cittadini dichiaratisi di lingua madre italiana, il che equivale ad un’estinzione “de facto” della nostra presenza;
è giusto altresì rammentare che il terrore titino non fu rivolto solo contro gli italiani, ma anche verso i popoli fratelli della Jugoslavia: solo per citare le più recenti notizie di fonte slovena, si ricorda (ottobre 2022) l’esumazione di oltre 3000 vittime di esecuzioni sommarie dalla fossa della Marčesna Gorica nel Kočevski Rog; la vicenda ha riportato alla mente anche altre più o meno recenti scoperte di luoghi di mattanze e orrori dovuti a Tito: Huda Jama (la caverna del Diavolo) e le sue 1500 vittime, i massacri della foresta di Kocevie e le fosse comuni con centinaia di crani trapassati da un proiettile, la Foiba dei bambini con oltre un centinaio di ragazzini di quindici anni gettati giù assiema a suore: si sono rinvenute tante piccole croci, bottoni e rosari;
nel solo territorio della Slovenia sono stati individuati più di 700 siti in cui sono state perpetrate stragi e la stima è di oltre 100.000 assassinati: i massacri ordinati da Tito, o svolti con la compiacenza del dittatore jugoslavo, avvennero nella quasi totalità dei casi a guerra finita, in pieno spregio di tutte le convenzioni internazionali: sono quindi tantopiù ingiustificabili e si configurano – al di là di ogni valutazione politica o storica – come crimini contro l’umanità;
da diversi anni, e per prima l’Unione degli Istriani, le associazioni degli esuli giuliani e dalmati hanno richiesto, esigendo rispetto, giustizia e umanità di fronte alla loro tragedia, la revoca dell’onoreficenza concessa a Josip Broz Tito, insignito il 2 ottobre 1969 dall’allora Presidente Saragat, del titolo di Cavaliere di Gran Croce decorato di Gran Cordone;
la richiesta-appello degli esuli istriani, nonostante la palmare evidenza delle ragioni addotte, è stata fin qui disattesa a causa di un’interpretazione che affermerebbe impossibile la revoca di un’onoreficenza a persone defunte, giacché alle stesse sarebbe precluso il diritto di opporsi alla stessa.
La materia è regolata dalla legge 3 marzo 1951 n. 178 che all’art. 5 prescrive: “Salve le disposizioni della legge penale, incorre nella perdita della onorificenza l’insignito che se ne renda indegno. La revoca è pronunciata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta motivata del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dell’Ordine”;
tale fattispecie è recentemente occorsa nel caso del presidente siriano Bashar Al Assad, decorato di Cavalierato di Gran Croce con Gran Cordone, conferitogli nel marzo 2010 e revocato nell’ottobre 2012 a causa della repressione feroce delle proteste sollevatesi nel paese attraverso l’uso delle armi e dei bombardamenti contro la popolazione civile, che determinarono decine di migliaia di morti. La revoca dell’onoreficenza fu allora sollecitata proprio da un atto parlamentare del Senato della Repubblica;
dalla legge 178/51 discendono i DPR 31 ottobre 1952 n. 178 (secondo cui «per ragioni di cortesia internazionale il Presidente della Repubblica può conferire onorificenze all’infuori della proposta e del parere richiesti» dalla legge 3 marzo 1951, n 178 e in questo caso il decreto di concessione è controfirmato dal Presidente del Consiglio dei ministri) e dal DPR 13 maggio 1952, n. 458 il quale all’art. 10 dispone che “le onorificenze possono essere revocate solo per indegnita’. Il cancelliere comunica all’interessato la proposta di revoca e gli contesta i fatti su cui essa si fonda, prefiggendogli un termine, non inferiore a giorni venti, per presentare per iscritto le sue difese, da sottoporre alla valutazione del Consiglio dell’Ordine. (…) Decorso il termine assegnato per la presentazione delle difese, il cancelliere sottopone gli atti al Consiglio dell’Ordine, per il parere prescritto dall’art. 5 della legge”;
in realtà l’attuale formulazione della legge non escluderebbe certo la previsione di revoca postuma dell’onoreficenza, giacchè, come recita il noto brocardo, “ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”;
ciò premesso,
il Senato impegna il Governo
a chiarire che il ritiro delle onoreficenze possa essere anche postumo in caso di morte dell’insignito e ad attivare di conseguenza la procedura di richiesta motivata al Presidente della Repubblica tesa alla revoca del Cavalierato di Gran Croce decorato di Gran Cordone al defunto dittatore jugoslavo, responsabile di crimini contro l’umanità, maresciallo Josip Broz Tito.
MENIA